Italian Graffiti – Percorsi italiani nella (s)memoria cinematografica collettiva a cura di Massimiliano Schiavoni
 La retrospettiva dell’ultimo Festival di Venezia, dedicata al cinema italiano d’avanguardia degli anni Sessanta e Settanta, è occasione propizia per tornare a parlare del cinema di Carmelo Bene. Al Lido è stato riproposto un suo cortometraggio, Hermitage, che ben si collocava nel percorso di reperimento delle tracce di un cinema totalmente dimenticato, in buona parte perché in Italia non esistono praticamente più spazi d’espressione per un cinema che sia ricerca, provocazione estetica, sfida alle categorie percettive di un pubblico sempre più pigro. La breve parentesi cinematografica di Carmelo Bene (5 lungometraggi, tutti compresi nel periodo 1968-1973) è a sua volta legata a doppio filo al Festival di Venezia. Con la sua opera prima, Nostra Signora dei Turchi, il Maestro leccese vinse al Lido il Gran Premio Speciale della Giuria. Salomè, invece, fu presentato in concorso nell’edizione del 1972, raccogliendo alla proiezione ufficiale reazioni scompostissime da parte del pubblico ben vestito e pettinato della Sala Grande. Insulti e sputi all’autore, che, al solito sardonico e provocatorio, rispondeva col gesto della benedizione. E, a quanto si narra, di fronte a tale reazione gli insulti e gli sputi diventavano sempre più virulenti. Perché cotanto “onore”? Perché, come tutta l’arte di Carmelo Bene, teatrale, letteraria o cinematografica che sia, anche Salomè (reperibile in dvd Medusa) costituisce una sfida violenta alle convenzioni espressive. Anzi, a detta di molti, nella scarna filmografia di Bene risulta addirittura l’opera più accessibile.
La retrospettiva dell’ultimo Festival di Venezia, dedicata al cinema italiano d’avanguardia degli anni Sessanta e Settanta, è occasione propizia per tornare a parlare del cinema di Carmelo Bene. Al Lido è stato riproposto un suo cortometraggio, Hermitage, che ben si collocava nel percorso di reperimento delle tracce di un cinema totalmente dimenticato, in buona parte perché in Italia non esistono praticamente più spazi d’espressione per un cinema che sia ricerca, provocazione estetica, sfida alle categorie percettive di un pubblico sempre più pigro. La breve parentesi cinematografica di Carmelo Bene (5 lungometraggi, tutti compresi nel periodo 1968-1973) è a sua volta legata a doppio filo al Festival di Venezia. Con la sua opera prima, Nostra Signora dei Turchi, il Maestro leccese vinse al Lido il Gran Premio Speciale della Giuria. Salomè, invece, fu presentato in concorso nell’edizione del 1972, raccogliendo alla proiezione ufficiale reazioni scompostissime da parte del pubblico ben vestito e pettinato della Sala Grande. Insulti e sputi all’autore, che, al solito sardonico e provocatorio, rispondeva col gesto della benedizione. E, a quanto si narra, di fronte a tale reazione gli insulti e gli sputi diventavano sempre più virulenti. Perché cotanto “onore”? Perché, come tutta l’arte di Carmelo Bene, teatrale, letteraria o cinematografica che sia, anche Salomè (reperibile in dvd Medusa) costituisce una sfida violenta alle convenzioni espressive. Anzi, a detta di molti, nella scarna filmografia di Bene risulta addirittura l’opera più accessibile.
Ripreso da un testo teatrale dello stesso Bene che rileggeva la Salomè di Oscar Wilde, il film, innanzitutto, è sfida al mezzo-cinema, condotta però secondo un atto di risalita ai principi fondanti di tale espressione artistica. Bene, infatti, provoca sui tre principali cardini espressivi del cinema: immagine, suono e montaggio. Sul piano visivo Salomè è un’esplosione di violenti contrasti cromatici, in 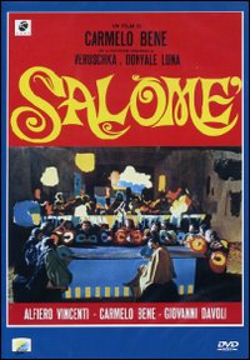 cui si cerca volutamente il kitsch più sfrenato per scardinare dalle fondamenta la convenzionale iconografia religiosa. Non soltanto tramite lo sberleffo tout court, ma anche tramite l’amplificazione (concetto a cui il Bene regista teatrale era particolarmente affezionato) della stessa iconografia. Ripetizioni ossessive, esplosioni di colore ed estrema messa in evidenza della finzione scenica. In colonna sonora Bene opera scelte nella stessa direzione: suoni ossessivi, digrignati, dialoghi e parole che si sovrappongono e scemano una nell’altra. Il dialetto, utilizzato in chiave dissacrante per il personaggio di san Giovanni Battista, ridotto a un livoroso semianalfabeta. La musica, che alterna brani di compositori classici a canzonette popolari (tanto per dire, Salomè si esibisce nella danza dei sette veli sulla base di “Abat-jour”…). Infine, il montaggio: un caleidoscopio di brevissime inquadrature che si susseguono convulsamente, tra macrodettagli fisici (predominante il primo piano), brandelli umani e un’incessante interlocuzione di frammenti talvolta indecifrabili. I tre elementi si compongono in una realizzazione estremamente compatta, dominata da una stringente unità di stile. Provocazione gratuita, forse? No. Semplicemente Bene ha sempre deciso, per sua stessa ammissione, di lavorare sui significanti, e mai sui significati. Ché per lui i significati non esistono. C’è un futuro per un simile cinema nell’attuale panorama italiano? L’unico futuro possibile è andare a rivedersi i suoi film.
cui si cerca volutamente il kitsch più sfrenato per scardinare dalle fondamenta la convenzionale iconografia religiosa. Non soltanto tramite lo sberleffo tout court, ma anche tramite l’amplificazione (concetto a cui il Bene regista teatrale era particolarmente affezionato) della stessa iconografia. Ripetizioni ossessive, esplosioni di colore ed estrema messa in evidenza della finzione scenica. In colonna sonora Bene opera scelte nella stessa direzione: suoni ossessivi, digrignati, dialoghi e parole che si sovrappongono e scemano una nell’altra. Il dialetto, utilizzato in chiave dissacrante per il personaggio di san Giovanni Battista, ridotto a un livoroso semianalfabeta. La musica, che alterna brani di compositori classici a canzonette popolari (tanto per dire, Salomè si esibisce nella danza dei sette veli sulla base di “Abat-jour”…). Infine, il montaggio: un caleidoscopio di brevissime inquadrature che si susseguono convulsamente, tra macrodettagli fisici (predominante il primo piano), brandelli umani e un’incessante interlocuzione di frammenti talvolta indecifrabili. I tre elementi si compongono in una realizzazione estremamente compatta, dominata da una stringente unità di stile. Provocazione gratuita, forse? No. Semplicemente Bene ha sempre deciso, per sua stessa ammissione, di lavorare sui significanti, e mai sui significati. Ché per lui i significati non esistono. C’è un futuro per un simile cinema nell’attuale panorama italiano? L’unico futuro possibile è andare a rivedersi i suoi film.
Il potente inizio del film, sulle note di un valzer di Sibelius:


